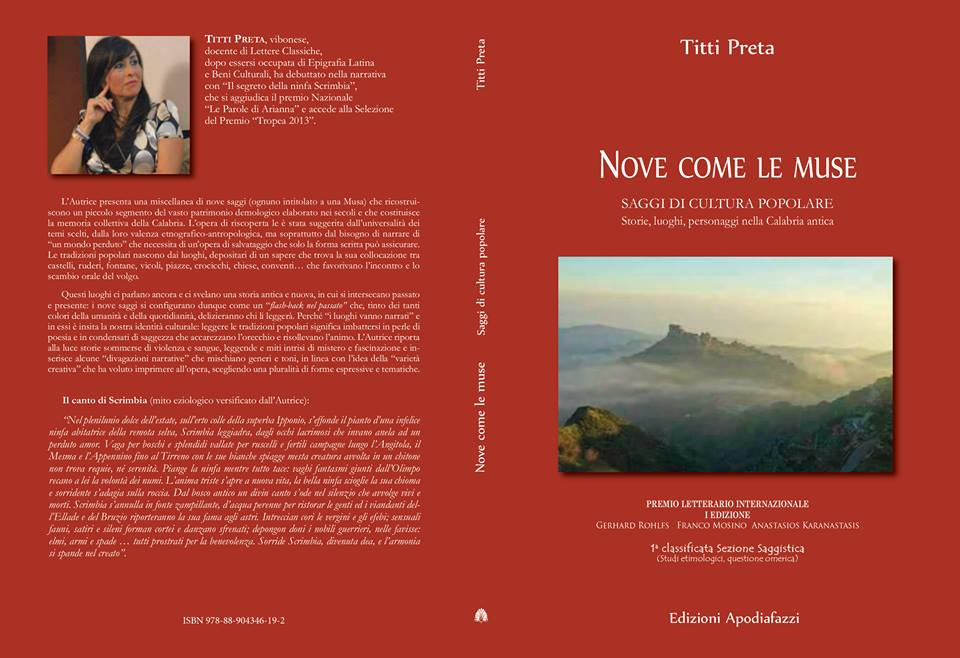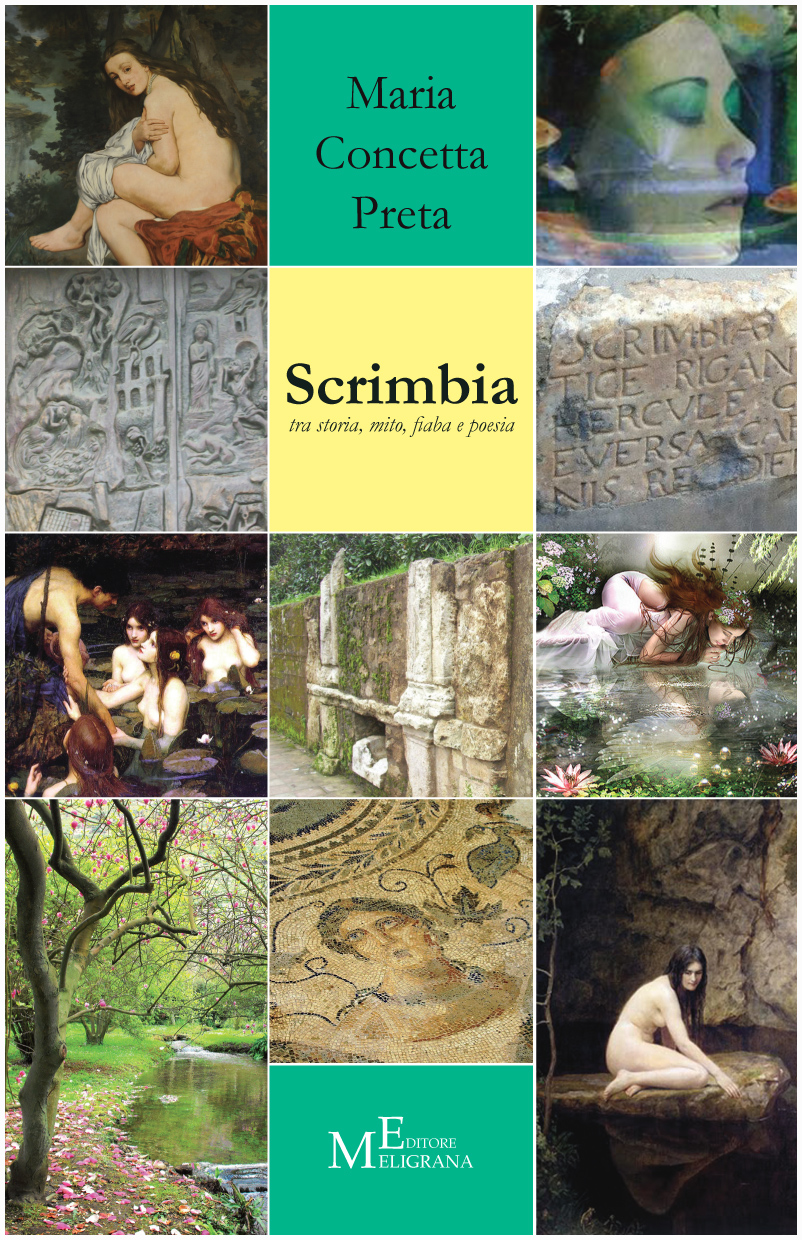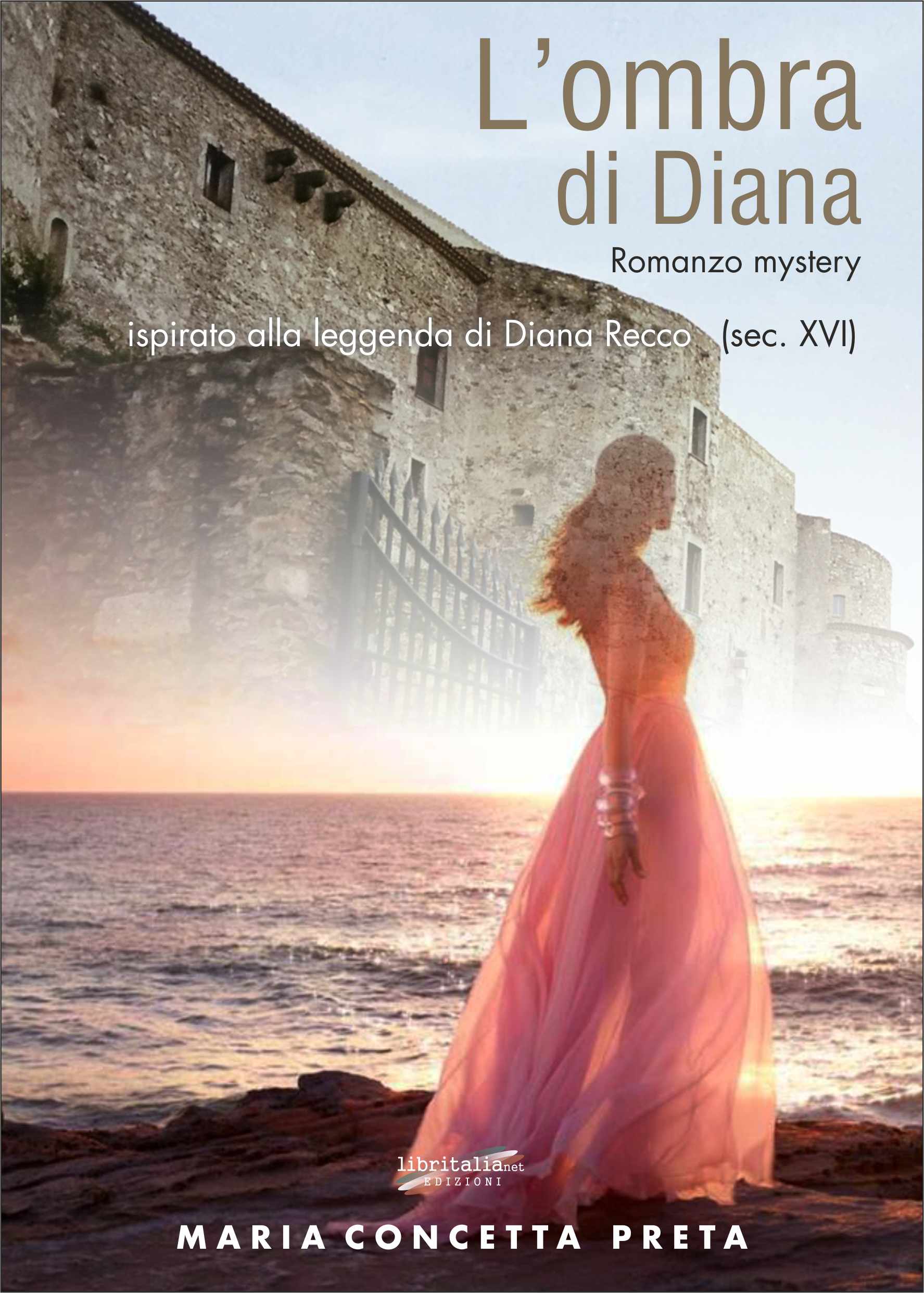Recensione del libro “Nove come le muse” della scrittrice Titti Preta
A cura dell’allievo Gianluca Porcelli della classe III° B del Liceo Classico M.Morelli di Vibo Valentia
Il libro “Nove come le muse” nasce dopo la vittoria del Premio Letterario Internazionale (prima edizione 2017) “Gerhard Rohlfs – Franco Mosino – Anastasios Karanastasis” (Bova, 3 settembre 2017) indetto dal Circolo Culturale “Apodiafazzi”, per la difesa e la valorizzazione della Lingua e Cultura Greco-Calabra. Sono presenti in questo volume nove saggi, ognuno intitolato ad una musa e contengono leggende, curiosità, aneddoti, tradizioni e novelle popolari. Tutto ciò trova luogo tra castelli, ruderi, fontane, piazze, vicoli, chiese, conventi e molti altri luoghi che ci svelano storie antiche ma anche moderne. Credo che il tempo dedicato alla lettura di questo libro sia stato tempo ben speso per la mia crescita culturale perché mi ha permesso di capire e riflettere molto sui luoghi e sull’identità della mia città e dell’intero popolo calabrese.
Saggio 1
Il primo saggio intitolato Calliope, la musa ispiratrice della poesia epica, parla della fontana e del mito della ninfa Scrimbia. Scrimbia è una zona della città, nei pressi del centro storico, dove sono stati rinvenuti molti reperti archeologici. Una leggenda narra che la Ninfa Scrimbia, era una giovane fanciulla ipponiate che non riuscendo a darsi pace per la morte del giovane amante Lisandro, piangeva ininterrottamente. Gli dei, rattristati e commossi per il continuo suo piangere, la tramutarono in una sorgente di acque fresche ed abbondanti affinché abbeverasse tutta la città. In suo onore fu costruita una fontana di cui, rimangono solo alcuni pezzi, mal collocati in un arido muro di cemento posto su Via A. De Gasperi. Con la Ninfa Scrimbia si apre il racconto storico scolpito da Giuseppe Niglia nel 1975, sulle porte del tempo del Duomo della Città. Inoltre, a lei si è ispirato l’artista locale Reginaldo D’Agostino nel realizzare la statua collocata all’interno della vasca che si trova in piazza Martiri d’Ungheria o Piazza Municipio.
Saggio 2
Il secondo saggio intitolato Erato, l’ispiratrice della lirica e del canto corale, narra la storia della dea Pandina e della dea Kore. Kore, era una bellissima fanciulla figlia di Zeus e Demetra ed era stata destinata in matrimonio dal padre a Ade signore degli Inferi e zio della fanciulla. In un giorno di primavera, mentre la fanciulla raccoglieva i fiori insieme alle sue compagne, Gea, la madre terra, fece spuntare davanti alle sue mani un narciso, fiore del sonno e della morte. La fanciulla, si chinò a raccoglierlo e all’improvviso si aprì la terra e dalle sue profondità sbucò Ade, che la rapì portandola nel suo regno e la fece diventare la regina dei morti con il nome di Persefone per i Greci e Proserpina per i Latini. La fanciulla invocava disperatamente sia il padre che la madre, ma nessuno sentiva la sua voce. Demetra si mise alla sua ricerca e, saputo del rapimento, implorò Zeus, finché il re dell’Olimpo e Ade non decisero che Persefone sarebbe tornata sulla terra a riabbracciare la madre e giocare con le altre fanciulle dall’inizio della primavera fino alla fine dell’autunno. Zeus, convinto da Demetra, aveva fatto di tutto per riportare la figlia sulla terra ma, poiché aveva gustato il melograno (frutto dell’amore) dovette fare un compromesso con Ade, che avrebbe trattenuto Kore per la durata dell’inverno con sé. Ad Hipponion lo storico e geografo greco antico Strabone di Amasea ambienta il rapimento di Kore da parte di Ade. Al Cofino vi sono i resti di uno spettacolare santuario per Demetra e Kore. La seconda storia presente in questo saggio parla della dea Pandina. Pandina è una dea ed in mancanza di notizie si è fatta più di un’ipotesi sull’origine della figura presente solo ad Hipponion su monete che la città coniò per un periodo di tempo limitato. La dea sulle monete appare del tutto ellenizzata, in posizione stante, con lungo chitone, scettro, caduceo e talvolta la corona. Sulle monete risalta la presenza del flagellum e la presenza della lancia che alludono alla vendetta e alla punizione divina. Nel vibonese si usa (anche se ormai molto meno di un tempo) l’imprecazione: “Mala Pandina ti pigli” ovvero “che tu possa essere colpito da sventure”.
Saggio 3
Il terzo saggio intitolato Clio, la musa della storia, racconta la leggenda dei Sette Martiri di Monteleone e di Diana Recco. Nel 1501 Federico II vendette Monteleone per 15.200 ducati a Ettore Pignatelli, prima della morte di Ferdinando D’Aragona. Morto il re, i documenti sono misteriosamente spariti e viene messa in dubbio la loro autenticità. La città, avutane notizia, organizzò la resistenza. I capi delle principali famiglie del paese erano riusciti a unire la città contro il dominio del nuovo duca. Questi, vedendosi in grave difficoltà, decise di invitare al castello i capi per trattare la resa. Il giorno dopo il duca espose dai merli del castello le teste dei rivoltosi, come monito per la città contro altri tentativi di ribellione. I nomi dei sette martiri (così furono definiti dalla tradizione) sono: Giovanni Recco, Ortensio Recco, G. Battista Capialbi, Domenico Milana, Francesco D’Alessandria, Sante Noplari e Tolomeo Ramolo. La leggenda vuole che ogni notte dell’8 giugno fino al giorno in cui i martiri non furono vendicati, scendesse dal castello e percorresse le vie principali della città, un cavallo che lanciava terrificanti nitriti e sprigionava faville dagli zoccoli. Dieci anni dopo Diana Recco, figlia e sorella di Giovanni e Ortensio, pugnalò a morte l’autore del massacro, tale Giovanni Lo Tufo, mentre a Lavello (PZ) partecipava alla cerimonia di nozze della figlia Maddalena.
Saggio 4
Il quarto saggio è intitolato Euterpe, la musa della musica e ci parla dei luoghi fatati di Monteleone. A Vibo Valentia, nella località del Cusello si narra la storia di un tesoro sepolto di cui era custode il così detto Schiavottu, il piccolo moro=arabo o turco-saraceno ed egli è un essere perfido che fa del male alla gente. Per venire in possesso delle ricchezze del tesoro bisogna affrontare situazioni abbastanza dure. Presso la fonte Cusello vi è una roccia di granito che è detta Ara del dio dell’oro, perché su di essa bisogna compiere un rito sacrificale che propizi la benevolenza dello Schiavotto. Il rito vuole che nella notte di Natale, proprio a mezzanotte, bisogna recarsi sul posto e, sotto il tesoro, si deve mangiare un melagrano di cui nessun chicco vada a finire per terra. È necessario compiere un infanticidio, si deve uccidere una creatura che compia in quella notte sei mesi di vita, con un colpo di spillo al cuore, la morte deve essere istantanea e macchiare la roccia, che diviene un altare sacrificale. Solo allora lo scoglio si rovescerà, lo Schiavotto uscirà fuori e cederà le sue ricchezze che si trovano dentro una grotta. Si tratta di una leggenda medievale e ovviamente nessuno riuscì a compierla. Il secondo luogo fatato di cui parla il quarto saggio è il largo G. B. Solari, nei pressi dell’ex Carcere cittadino, un tempo Convento degli Agostiniani Calceati in cui si trova murata allo spigolo di un edificio un’epigrafe in caratteri latini: CAVE A LACRYMIS COCODRILLI ossia il famoso detto: “Guardati dalle lacrime di coccodrillo”.
La piccola iscrizione troverebbe una spiegazione nella favola popolare di un monaco del vicino convento di sant’Agostino. Il monaco si chiamava Fra’ Gerolamo ed era un tipo irritabile e solitario. Un giorno scoppiò una lite tra Fra’ Gerolamo e un confratello per futili motivi. L’irascibilità portò il monaco ad uno scontro non solo verbale e dovettero dividerlo dal rivale che lo accusava chissà di cosa. Questo confratello, giovanissimo, morì alcuni giorni dopo, per motivi non precisati. Nel convento e nella rocca di Monteleone si diffuse l’idea che si fossero avverate le maledizioni scagliate da Fra’ Girolamo al nemico. Dopo alcuni mesi Fra’ Gerolamo s’imbatté nella stessa sorte di una morte improvvisa e non naturale. Il suo corpo venne trovato martoriato e con il cranio sfondato. Secondo la versione ufficiale la morte di Fra’ Gerolamo fu causata in seguito a una caduta dalle scale. Nacque tra il popolo monteleonese la diceria che nel colmo della notte, si udissero voci umane nel convento. Anche il nuovo monaco che aveva occupato la cella del frate notò strani fenomeni. Una sera, nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della morte di Fra’ Gerolamo, una giovane monteleonese, che abitava vicino al convento, uditi gemiti e lamenti, si alzò dal letto e uscì fuori per capire da dove provenissero. Non rientrando a casa, la madre uscì a cercarla e mentre camminava trovò il corpo della figlia disteso a terra. La ragazza aveva subito una violenza atroce che sconvolse tutti gli abitanti.
Il terzo luogo fatato è il castello di Ruggero il Normanno. Nel XI sec. d.C. un conquistatore di nome Ruggero D’Altavilla, giunse dal Nord dell’Europa a Vibona (Vibo Valentia) ed attratto dalla storia del luogo decise di stanziarsi in questi luoghi pur scegliendo Mileto come capitale e ordinò di costruire una torre strategica sul colle, per controllare l’intero territorio. In seguito, Svevi ed Angioini, nuovi dominatori, fortificarono con il passare del tempo la piazzaforte e costruirono anche un circuito murario per protezione, detto Borgonovo, cui diedero impulso e vitalità. Sotto gli Aragonesi, il toponimo fu definitivamente Monsleo e il leone rampante divenne l’emblema della civitas. Il fondatore del castello, per via di un incantesimo, è condannato ad entrare, in groppa al suo cavallo, in un cunicolo lunghissimo, che sarebbe dovuto arrivare fino alla marina di Bivona. Se esista davvero questo tunnel, non si sa ma si dice che là sotto ci sono spiriti maledetti e il fantasma di Ruggero è il vero padrone di quel luogo. Nasce così il castello di Vibo Valentia.
Un altro luogo fatato di Vibo Valentia è la “Silica” dove si trova una nota fontana, proprio qui sorge una costruzione edificata secondo un progetto anomalo. Il suo nome è Villetta Fabiani e vi furono una splendida biblioteca, sede di un cenacolo letterario, e un Gabinetto di Scienze i cui pezzi furono donati alle Regie Scuole per l’allestimento di un laboratorio di fisica. La cappella familiare era intitolata a sant’Anna e ogni anno, il 26 luglio, è tradizione svolgere una processione fino a “Sant’Anna presso la Silica”. La residenza apparteneva a una nobile famiglia dell’antica Monteleone, i Fabiani, dei quali un esponente, Giovan Pietro, partecipò nel XVIII secolo a una congiura contro i signori della città, i duchi Pignatelli, che avevano imposto con la violenza il loro regime feudale. Ci furono rappresaglie, accuse e diffamazioni, finché la feudalità fu soppressa nel 1806. Dopo il fallimento della congiura, i Pignatelli perseguitarono i Fabiani per le idee libertarie. La proprietà gli fu confiscata, la famiglia si spostò altrove e ciò comportò il declino della casata e la dispersione dei beni. Secondo le credenze popolari, vi dimorava una vecchia strega dal volto bianco smorto, occhi incolore e pelle rugosa. Essa era sempre avvolta in uno scialle nero, lungo sino ai piedi, ed era la strega del posto, detta la magara.
L’ultimo luogo fatato di cui parla il quarto saggio è la via Paolo Orsi dove si trovano le Mura Greche.
Nei pressi delle mura greche di Hipponion, sono stati avvistati in tempi diversi dei fantasmi. C’è chi sostiene di aver visto un corpo luminoso, con in testa un copricapo con pennacchio, nel 1923 un contadino aveva scalzato una lastra di terracotta dal suolo con l’aratro, appena si chinò avvertì strani odori di bruciato e sentì un tonfo. Rialzatosi, vide il bue che prima trainava l’aratro, morto stecchito. L’uomo allora comprese di aver infastidito uno spirito il cui corpo giaceva sotto i suoi piedi, perciò decise di rimettere a posto la copertura del suo sepolcro, gettò di sopra dei fiori e pose un bastone come segnacolo per non tornare più ad arare quel terreno. Diede poi fuoco alla carcassa del bue pensando che le carni fossero avvelenate. Un giorno un ingegnere mentre guidava, uscì fuori strada inspiegabilmente e morì schiantandosi contro un cipresso. Il tetto dell’auto era sporco di sabbia e frammenti di pietra calcarea, simili per materia ai blocchi delle mura di Hipponion. In Calabria sono ancora in molti a credere che quando si è subìto un torto prima o poi ci sarà una sorta di ‘giustizia’.
Saggio 5
Il quinto saggio, intitolato Melpomene, la musa del canto e della tragedia, parla delle superstizioni e delle ritualità funebri. Secondo una credenza nella notte di S. Giovanni, appare in cielo, sulla cima di un monte immaginario, una trave di fuoco, dove sono sedute la giovane Salomè e la madre Erodiade e si odono i lamenti delle due donne. L’ immaginazione popolare crede che in questa notte ci sia qualcosa di magico. Le fanciulle, quando i rumori delle vie cessano, si affacciano alle finestre o sull’uscio di casa e pregano affinché i loro desideri siano esauditi. Mentre i rumori uditi fermano l’attenzione della gente superstiziosa. Il canto della civetta è segno di prossima sventura, il cane che abbaia indica che c’è della gente che ti vuol male, i canti ed i suoni allegri indicano gioia prossima ad avverarsi e molte altre. Nella Calabria antica per far capire che in casa si teneva il lutto veniva esposto sulla porta di strada un panno nero e rimaneva fino a quando non si scolorava ed era fatto a brandelli. Il trasporto del cadavere si differenziava in base alla famiglia, ma in generale, non si badava a spese. I signori e le persone ragguardevoli erano scortati da un gran numero di carrozze (pompa magna) che, mandate gratis dai padroni, costavano comunque un occhio per la mancia da porgere ai cocchieri. A Monteleone la bara era circondata da donne che portavano in capo grandi vasi in cui bruciava l’incenso. Se il morto fosse stato persona importante, sarebbe stato scortato in chiesa ed esposto alla vista del pubblico su di un alto catafalco. In alcuni paesi, il cadavere si chiudeva in una cassa fatta alla maniera dei sarcofagi antichi, ornata di maniglie e coperta di panno in velluto rosso o nero. I poveri si accontentavano di una cassa seriale. Accompagnato il cadavere, si svolgeva il cordoglio a casa del defunto, dove i parenti tenevano un lungo lutto. Talvolta il lutto era consolato dal cibo ovvero da graditi rinfreschi che mandavano gli amici stretti. Con il passare dei tempi i vecchi monteleonesi si lamentavano che il cordoglio non si svolgeva più come una volta. Il malato, dopo morto, viene vestito, posto nella bara e il suo materasso viene buttato per terra. Il lutto dura tre giorni e alla sera dei giorni di lutto, i parenti lontani e gli amici stretti mandano il mangiare alla famiglia del morto e questo si chiama ‘u cuonzulu (consolazione). In Calabria nei tre giorni di lutto, le donne che erano parenti del defunto sedevano sul materasso del morto, gettato a terra. Si pensava che l’anima del defunto si aggirasse più giorni per casa, così per otto o dieci notti si teneva accesa una lampada perché il morto camminasse liberamente. Dopo i tre giorni, finestre e porte rimanevano chiuse e le vedove portavano il nero per molte settimane. In un villaggio greco albanese di Nicastro, le donne piangevano sul cadavere con un lamento di esclamazione: Sventurata. Mentre gli uomini non si abbandonavano al pianto, ma esprimevano il loro dolore col ravvolgersi nei mantelli anche in piena estate, come facevano gli antichi romani. Quasi in tutta la Calabria di un tempo, il rito funebre veniva accompagnato dai canti e riti delle reputatrici, dette nel monteleonese chiangitari e trivuli: donne esperte nell’arte del pianto. Col tempo, alla pietà subentrò il mestiere e le preficae, pretio conductae (spinte dal guadagno) misuravano il pianto dal compenso che ne ricevevano. Questa usanza che ormai per certe persone era divenuta un mestiere vero e proprio continuò nel tempo fino a quando la chiesa guidata dal papa Innocenzo III si scagliò contro di essa. Nonostante ciò, l’usanza perdurò nella Bassa Italia e in Corsica e si perse solo col mutare dei costumi.
Saggio 6
Il sesto saggio, intitolato Polimnia, la musa dell’orchestra, della pantomima e della danza associate al canto sacro ed eroico, parla di alcune vicende che si sono verificate in Aspromonte. La prima storia vede come protagonisti Antonia e Bernardino che sono due vittime d’amore ed è ambientata in un paese abbandonato chiamato Pentedattilo. La leggenda del paese di Pentedattilo risale al 16 aprile 1686 e a caratterizzarla sono la violenza, l’inganno e la vendetta. Nel XVII secolo la Calabria era dominata dagli Spagnoli che instaurarono un dominio basato sulla forza. Esisteva da tempo un’accesa ostilità tra il feudo di Pentedattilo e quello di Montebello e per porre rimedio a ciò, nel 1685 gli esponenti delle due famiglie in contesa, il marchese di Pentedattilo Lorenzo Alberti e il barone di Montebello Bernardino Abenavoli del Franco, decisero di fare un patto per arginare i lunghi contrasti. Un giorno il barone Bernardino fu designato padrino al battesimo della figlia del marchese Francesco Alberti ma durante i festeggiamenti, il barone si innamorò della giovane figlia dell’Alberti, la marchesina Antonia e questo amore rimase segreto. Qualche mese dopo, al marchese Francesco successe il figlio Lorenzo, che fu promesso in matrimonio a Caterina, figlia di Don Pietro Cortez, signore di Napoli e consigliere del Vicerè d’Aragona. Le nozze tra il marchese Lorenzo Alberti e Caterina Cortez si sarebbero tenute nel potente e ricco feudo di Pentedattilo e dopo un po’ di tempo si cominciarono ad avviare i preparativi del matrimonio così Don Cortez giunse a Pentedattilo con la famiglia, il figlio del Cortez, il giovane Don Petrillo rimase colpito dalla bellezza di Antonia e decise di chiederla in sposa al padre Lorenzo che acconsentì subito. Antonia, molto legata al barone Bernardino, non potendo contrastare la decisione paterna, informò il suo amato della novità. Il barone Abenavoli si sentì tradito sia perché avrebbe perso la sua amata, e sia perché non poteva tollerare la presenza di un feudo così forte nel vicino territorio. Così il 16 Aprile 1686, notte di Pasqua, aiutato da uno traditore, Peppino Scrufari, e con il consenso della marchesina Antonia, penetrò nel castello Alberti di Pentedattilo, uccise le guardie e il marchese Lorenzo venne colpito a morte dal barone e dallo Scrufari, davanti agli occhi della moglie. Anche la marchesa madre, insieme ai figli, venne brutalmente trucidata e la bella Antonia sarebbe stata violentata sul luogo dell’eccidio. Il barone Abenavoli prese in ostaggio Don Petrillo Cortez, si serrò nel suo castello di Montebello dove fece celebrare le nozze forzate con la marchesina Antonia, che iniziò a odiarlo per la strage inferta alla sua famiglia. La notizia dell’eccidio di Pentedattilo si diffuse nel regno delle Due Sicilie. Il viceré di Spagna, decise di intervenire e inviò la sua fanteria, che assediò il castello baronale di Montebello e prese in ostaggio gli otto principali artefici del massacro dei marchesi Alberti che furono orribilmente trucidati e dai merli del castello di Pentedattilo vennero esposte le teste mozzate di sei di loro. Don Petrillo Cortez fu tratto in salvo e condotto a Reggio, mentre la marchesina Antonia, rimasta orfana, fu rinchiusa a vita in un conservatorio femminile. Riguardo l’epilogo della tragedia di Pentedattilo, erano state tramandate due versioni. Secondo la prima, il barone Abenavoli, sfuggito all’assedio spagnolo dal suo castello, si sarebbe nascosto nel convento dei padri Francescani presso il Crocifisso a Reggio Calabria, evitando la cattura travestito da frate. Da qui avrebbe continuato a nascondersi in diverse località della Calabria. Secondo la seconda versione, Bernardino, imbarcatosi alla Marina di Brancaleone, sarebbe scampato a Malta e, da qui, sarebbe giunto a Vienna per diventare miliziano dell’imperatore. Alla corte viennese degli Asburgo sarebbe stato riconosciuto da un suo vecchio mandriano, Andrea Tripodi, pure lui rifugiato presso l’imperatore. Il barone Bernardino, svelata la sua identità, si sarebbe prostrato ai piedi della Maestà Imperiale per chiedere perdono. Così Bernardino, avrebbe servito la corona austriaca e avrebbe finito i suoi giorni in mare, colpito da una palla di cannone mentre combatteva i Turchi, il 22 agosto del 1692. La seconda e ultima storia parla della violenza sulle donne in Calabria. La storia delle donne anche in Calabria è segnata da dolori passati e recenti. Molto conosciuta quanto vera è la vicenda di Elisabetta Survara, vissuta nel XVII secolo, che reagisce alla violenza e denuncia il suo carnefice. Il 14 maggio 1631 Elisabetta denuncia l’abuso, già perpetrato l’anno precedente (riportato nell’atto XIX), da parte del Capitano Scambelluni. Elisabetta viveva da sola nel casale di Molochiello e a quei tempi una donna così veniva considerata “leggera”. In realtà lei non aveva scelto la solitudine ma probabilmente aveva perso i suoi familiari per colpa di epidemie, pestilenze o guerre. Si accorge di lei il capitano del contado di Condoianni, che faceva parte del feudo di Castelvetere, Salvatore Scambelluni. Il capitano Scambelluni per farla sua utilizza, come spesso fa, una mezzana, tale Melchionna Manderano di Gerace, alla quale dà l’incarico di avvicinare Elisabetta, invitandola ad accettare le sue profferte, ma Elisabetta non lo accetta. Così Scambelluni decise di fargliela pagare, entra nella casa di Elisabetta con inganno e la violenta ripetutamente. Elisabetta sentendosi offesa nella sua dignità di donna decise di affidarsi alla legge. Lo Scambelluni intuisce e minaccia la donna, però lei non si ferma. L’esito di questa storia non si sa ma si trattava comunque di una donna coraggiosa e unica per l’epoca.
Saggio 7
Il settimo saggio intitolato Talia, la musa che presiede alla commedia ed alla poesia bucolica, parla della maga Sibilla. Si dice che sul versante est dell’Aspromonte, ai piedi del Puntone di Juncàri a 1700 metri circa d’altezza, si trova il Vallone della Sibilla. Si narra infatti che qui si fosse ritirata la maga (magara) Sibilla, arrabbiata del fatto che non fosse lei la prescelta da Dio per dare la vita al Messia. La Sibilla, esperta di profezie, ogni giorno interrogava le sue allieve sui loro sogni. E così, un giorno viene a sapere da Maria, futura Madonna, che ha sognato un raggio di sole che l’aveva illuminata e che le era penetrato nel cuore e la Sibilla comprende subito che sarà lei la prescelta. Così giura vendetta contro quelle genti e quei luoghi e si ritira in una grotta tra i monti. Per difendere l’Aspromonte dalle profezie della Sibilla viene edificato il Santuario della Madonna di Polsi e ogni anno il 2 settembre, finita la processione, la statua della Madonna viene rivolta col volto verso il vallone della Sibilla. La tradizione della Sibilla aspromontana è antica e complessa ma ben radicata nelle tradizioni popolari della Calabria. Nel romanzo del Guerrin Meschino, si legge, che il Meschino, arrivato a Reggio Calabria, sente per la prima volta parlare della Sibilla. Questa storia conosce molte varianti. In una di queste, si legge che la Sibilla abitava in un palazzo incantato nell’Aspromonte. Un’altra variante dice che la Madonna racconta alla maestra-maga il suo sogno e che la Sibilla, improvvisamente, costringe le discepole a gettare nel fuoco i loro lavori, in modo che si perda ogni scienza, ma la Vergine Maria nasconde il suo sotto l’ascella e divenne madre di Cristo. Mentre la mamma Sibilla, con tutta la sua scienza, fu condannata ad abitare sull’Aspromonte, dove ancora continua a stregare la povera gente. Nella fiaba della Sibilla si narra che tanto tempo fa, fra le aspre rocce dell’Aspromonte, sorgeva un castello dove viveva la Sibilla e suo fratello Marco. Dalla Sibilla le famiglie più illustri mandavano le figlie ad apprendere le arti e le scienze. Essendo la Sibilla la donna più sapiente del tempo, a lei sola era dato conoscere la scrittura. Ella scrisse dei libri e li diede alle alunne affinchè ne tramandassero l’uso. Un giorno una bimba di nome Maria narrò d’aver sognato che un raggio di sole, entratole nell’orecchio destro, le era uscito per il sinistro. La Sibilla interpretò il sogno e capì che quella dolce creatura era destinata ad essere la madre del figlio di Dio, così presa dall’ira, volle distruggere il mezzo di tramandare l’arte, le scienze e le dottrine. Accese un fuoco ed ordinò alle bambine di buttare nelle fiamme i loro libri. Ma la piccola Maria riuscì a nascondere il librettino tra le vesti. Passarono gli anni e la Sibilla diventò cattiva e le fanciulle non andarono più da lei. Un giorno udì che il Cristo era nato da Maria e andò a cercarlo e quando lo vide, lo colpì sulla guancia destra. Dopo tanti secoli, il castello scomparve tra fitte boscaglie e cumuli di spine. Nella valle di Polsi, sorse un Santuario dedicato alla Madonna e la gente va a salutare Maria con pellegrinaggi e portando il dono che le ha promesso. In Calabria si pensa che i folletti (fajetti) infestano molti luoghi misteriosi, senza far del male a nessuno, a parte qualche scherzo ai contadini anziani. Mentre per le streghe si crede che entrino in casa e sono dispettose. Infatti, si recita un antico detto che dice: “Salva la vita ad una strega e ne rimarrai vittima”. Nella storia della strega e del contadino si racconta che una notte, dopo essersi recata a un sabba infernale, una strega, era stata colta dall’alba. Il demone accompagnatore, spaventato dalla luce, l’abbandonò sulla strada, così la strega cadde a terra e in breve tempo si trovò quasi in fin di vita. Il sentiero era distante dal centro abitato e passò del tempo, prima che un viandante si accorgesse del corpo della strega steso a terra. Il povero contadino, pronto a soccorrere la donna, la raccolse e la condusse a casa sua, e qui la curò per due giorni e due notti. Quando finalmente si riprese, il contadino iniziò a farle un mucchio di domande. La strega cercava di sfuggire sempre a quelle domande perchè non voleva nuocere al suo salvatore. Se avesse risposto in modo sincero, il contadino non sarebbe sopravvissuto dopo aver ascoltato le parole della donna. Ma l’uomo era curioso, e fu costretta a raccontargli del luogo da cui stava rincasando. Il racconto fu fatale al contadino e di lui furono solo ritrovati i vestiti sul bordo di un sentiero poco battuto, vicino ad un cimitero.
Molto conosciuta è la storia di Cecilia Faragò, essa è imputata di stregoneria nell’ultimo processo che si sia svolto in Italia.
 La donna era accusata da due prelati di Soveria Simeri, don Domenico Vecchitti e don Francesco Biamonte, di aver provocato, con la “malìa”, la morte del canonico don Antonio Ferrajolo. Nonostante avesse un figlio, Sebastiano, monaco francescano, la Faragò era accusata di sortilegi, attuati attraverso strane pozioni fornite da una “donna di malavita” di Catanzaro o da un viperaio del luogo. Il Regio Commissario catanzarese D’Elia aveva fatto sequestrare dalla sua casa rurale diversi corpi di reato. La Faragò infatti usava delle sostanze velenose per provocare la morte degli uomini e delle bestie.
La donna era accusata da due prelati di Soveria Simeri, don Domenico Vecchitti e don Francesco Biamonte, di aver provocato, con la “malìa”, la morte del canonico don Antonio Ferrajolo. Nonostante avesse un figlio, Sebastiano, monaco francescano, la Faragò era accusata di sortilegi, attuati attraverso strane pozioni fornite da una “donna di malavita” di Catanzaro o da un viperaio del luogo. Il Regio Commissario catanzarese D’Elia aveva fatto sequestrare dalla sua casa rurale diversi corpi di reato. La Faragò infatti usava delle sostanze velenose per provocare la morte degli uomini e delle bestie.
Saggio 8
L’ottavo saggio è intitolato Tersicore, la musa che protegge la danza e racconta novelle popolari monteleonesi. La prima novella che viene presentata s’intitola “Le penne dell’uccello falcone”. Tanto tempo fa c’era un re che aveva tre figli maschi e l’ultimo si chiamava Peppinello ed era il figlio prediletto. Un giorno il re si ammalò di lebbra e non si riusciva a farlo guarire. Il medico gli disse che per guarire doveva ungersi con le penne dell’uccello Falcone. Così il re chiamò i tre figli e li mandò a cercare queste penne e chi le avrebbe trovate sarebbe stato degno della sua corona. I figli partirono in tre città diverse: Napoli, Roma e Torino. Peppinello andò a Napoli e si dimenticò del padre consumando tutti i soldi. Si ritrovò morto di fame e pregava Dio di trovare questo uccello Falcone. Un giorno iniziò a piangere, San Nicola si accorse di lui e gli indicò per dove doveva andare. Quando arrivò nella pianura sotto la quercia trovò l’uccello e il giorno dopo mentre stava tornando a casa, sulla strada vide i suoi fratelli avvolti in stracci. Peppinello portò i fratelli da un merciaio per rivestirli da capo a piedi ma durante il ritorno i fratelli gli chiesero se avesse trovato le penne dell’uccello Falcone, e Peppinello raccontò il fatto di San Nicola. I due fratelli invidiosi, lo ammazzarono per prendersi le penne magiche. Il giorno dopo i fratelli arrivarono alla reggia e consegnarono le penne al padre. Il re guarì ma chiedeva sempre di Peppinello. Dopo tanto tempo, un pastorello mentre guardava le sue pecore nel campo dove i fratelli malvagi avevano atterrato Peppinello, si mise a scavare la terra con un bastone e trovò un osso liscio e bianco. Pulì l’osso e ne ricavò un fischietto. Appena lo avvicinò alla bocca udì una vocina che gli diceva: “Pastorello che alla bocca mi tieni, tienimi forte e tienimi bene. Me, che per le penne dell’Uccello Falcone, m’hanno ammazzato i fratelli birboni!”. Il pastorello capì che il fischietto era fatato e pensò di ricavarne denaro. Dal giorno seguente si esibiva nelle piazze dei paesi dove la gente si radunava per sentire la vocina del fischietto magico. La sua fama di mago si diffuse e giunse alla corte del re che volle metterlo alla prova. Il pastorello si presentò al trono del re e il re avvicinò alla sua bocca il fischietto magico per chiedere della sorte di suo figlio e uscì questa vocina: “Caro padre che alla bocca mi tieni, tienimi forte e tienimi bene. Me, che per le penne dell’Uccello Falcone, m’hanno ammazzato i fratelli birboni!”. Il re si mise a piangere e chiamò la regina insieme ai figli che suonarono il fischietto. A quel punto si adirò contro i figli e disse al pastorello che gli avrebbe dato 100 ducati se l’avesse portato nel luogo dove aveva trovato l’osso. Il pastorello lo portò, trovò le spoglie del figlio, le fece dissotterrare e lo seppellì nel tumulo reale. Poi tornò alla reggia e mandò via i suoi due figli. La seconda storia parla di un fatto di cui il re Salomone riuscirà a trovare la soluzione. Un ricco signore, sposato con una donna virtuosa, si sentiva l’uomo più felice del mondo. Quando nacque il primo figlio, il padre chiamò gli astrologi perché leggessero nelle stelle il suo destino e gli dissero che, una volta cresciuto, ucciderà tutti i cristiani che incontrerà. Nonostante ciò, sperò in un nuovo figlio e, dopo nove mesi, la moglie mise al mondo un altro maschio. Così chiamò gli astrologi per avere la lettura del destino del figliolo e gli dissero che sarà un ladrone. Con l’arrivo del terzo figlio, chiamò nuovamente gli astrologi per conoscere il destino del piccolo, e gli astrologi gli dissero che sarà un peccatore. Quindi pensava ancora ad un nuovo nascituro e con il nuovo anno la moglie partorì il quarto figlio. Il padre, pieno di speranza, richiamò gli astrologi per la lettura del destino e gli dissero che il quarto figlio è un pervertito. Il padre pianse la sorte dei suoi figli e decise di recarsi dal re Salomone, il più saggio degli uomini. Quando arrivò davanti al re posò i ducati sopra il tavolo e iniziò a parlare del primo figlio che sarà un omicida. Ma Salomone gli disse di farlo medico così ammazzerà quanti cristiani desidera e sarà pure pagato per farlo. Poi posò i 100 ducati per il secondo figlio riferendo che sarà un ladrone, e Salomone consigliò di farlo avvocato, così potrà rubare quanto vorrà. Il signore lo ringraziò e diede a Salomone i 100 ducati per il terzo figlio, dicendo che sarà un peccatore ostinato. E Salomone gli consigliò di farlo prete così si paluderà del manto della misericordia. Il signore ancora una volta lo ringraziò e pose sul tavolo i 100 ducati per il quarto figlio, dicendo che è nato effeminato. Allora Salomone gli disse di riportarsi indietro i ducati perché non c’è niente da fare, la sua saggezza ha salvato i primi tre figli ma nulla può fare per chi va contro natura.
Saggio 9
Il nono e ultimo saggio è intitolato Urania, la musa dell’astronomia e della geometria e parla della fiaba di Ruggero e Morgana. Il Conte Ruggero I d’Altavilla giunge in Calabria e la percorre tutta a cavallo. Valica montagne, guada fiumi, attraversa vallate, boschi, per molti giorni. Fin quando arriva nella bassa Sila e dà l’ordine alle truppe di arrestarsi. A questo punto i soldati chiedono se si devono fermare lì ma il conte, non ancora sazio di dominio, fa cenno di no con il capo e ricomincia la lunga cavalcata. Poi, giunge la notte e le truppe si accampano sui monti sopra Reggio. Nell’accampamento si accendono i fuochi e non si riesce a dormire perché si sentono da lontano canti e danze di guerra. Il conte Ruggero, molto nervoso, si mette a camminare in un gelseto e incontra un vecchio eremita. Si guardano, in silenzio, poi Ruggero gli chiede da dove viene quest’odoro e questa lagna che gli invadono i sensi e l’eremita gli risponde che oltre il mare c’è la Sicilia dove fioriscono i giardini, là piangono i cristiani in catene e danzano i Saraceni. Quando spunta il sole, il conte normanno vede i saraceni che procedono in file lunghe con le loro carovane e confida al suo scudiero che un giorno conquisterà la Sicilia anche se la sua crociata dovesse durare trent’anni. Dal fondo del mare queste parole sono state udite da una fanciulla chiamata fata Morgana che svela la sua potenza solo a chi dimostra di avere coraggio e cuore mettendolo sempre alla prova. Così decide di apparire a quel re normanno perché sa che senza il suo aiuto non ci sarebbe mai riuscito. All’alba del nuovo giorno, Morgana appare a Ruggero e lo invita a salire sul suo carro incantato per arrivare in Sicilia. Ruggero non vuole accettare così Morgana prende la sua bacchetta incantata, lancia tre sassi in mare e dice a Ruggero di ammirare la sua potenza. Subito l’isola si avvicina a Ruggero e Morgana lo prega di nuovo a salire sul carro così diventerà il re della Sicilia ma Ruggero la manda via dicendo che lui è un conte cristiano e obbedisce solo alle leggi di Dio. Improvvisamente la fata sparisce e con lei si allontana l’intera isola. Il conte Ruggero raduna le sue navi per andare a combattere ma impiegherà trent’anni per conquistare la Sicilia.
Gianluca Porcelli, classe 3 b Liceo Classico Morelli – Vibo Valentia